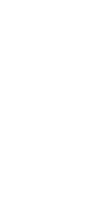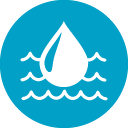La filosofia delle relazioni nel contemporaneo per comprendere il mondo in cui viviamo
Intervista ad Antonio De Simone, filosofo e saggista, professore di Storia della filosofia e Filosofia della cultura all’Università di Urbino Carlo Bo.
A cura di Andrea Paolinelli
Abbiamo intervistato il prof. Antonio De Simone, socio e co-Presidente della Commissione Forme di Cultura del Rotary Club Urbino, per svolgere alcune riflessioni sull’ambiente sociale contemporaneo, al fine di individuare il filo conduttore sulle modificate attitudini delle relazioni interpersonali, sul flusso del vivere che si sviluppa e si trasforma continuamente, anche alla luce della recente pandemia.

Nella filosofia, nelle scienze umane e nella fenomenologia del tempo vissuto e del tempo pensato, c’è un nesso storico nell’agire umano?
Tu Andrea rievochi con sguardo retrospettivo alcuni transiti della nostra biografia pubblica. Eravamo allora nel Novecento. Un tempo della storia e del nostro essere nel mondo. Oggi, nel XXI secolo, nella nostra contemporaneità, viviamo un tempo scardinato, schiacciati in una perenne attualità, in una schiavitù del presente che ci pone dentro l’abisso come naviganti nell’in-finito in un oceano sconosciuto, senza capacità di rispondere a una situazione di incertezza, di vulnerabilità, di crisi. Una condizione di gettatezza. Un crepuscolo che ancora non ci fa intravedere un nuovo presente e un futuro a breve termine. Nel teatro dell’agire umano, nelle nostre forme di vita, la scena è calcata, nel palcoscenico della storia, dal suo personaggio e protagonista principale: il conflitto tragico. La tragedia scatena su di noi i suoi effetti più violenti. Ci rende fragili pur nell’apparente velocità e accelerazione dei flussi artificiali della tecnologia e dell’informazione. Questo è l’odierno stato del mondo che, a partire e attraverso il disincanto tragico del Moderno, possiamo comprendere anche con Hegel, Max Weber e Jürgen Habermas. Sul piano dell’agire politico, potrei dire con Machiavelli, che il nostro mondo è “guasto” e rovesciato. Ho fatto riferimento a questi grandi pensatori perché è verosimile che ogni generazione deve “reinventare” i classici. La loro “lezione” persiste. È illusorio credere di aver chiuso con il passato quando esso stesso non ha affatto chiuso con noi. Il problema è come procedere oltre le ambiguità del passato e del nostro presente. Nuove forme di intersoggettività potranno e dovranno affrontare le difficili sfide che sono ancora davanti a noi.
Mi sembra di comprendere, quindi, che il nesso storico sia il “conflitto tragico”, la“tragedia”. Può spiegare questo concetto?
Nella nuda specie dell’umana mortalità, la tragedia disvela ai nostri occhi ciò che noi non sappiamo di noi stessi nel nostro procedere, nel nostro divenire, nella sconvolgente esperienza del disorientamento in cui non sappiamo “cosa fare”, come dobbiamo “agire”. Siamo nel gorgo dell’esistenza, nel “distanziamento” dell’essere, nell’esperienza temporale, in una temporalità in costante fluire, che nella fattualità della vita e nel processo storico concreto ci co-stringono, tra passato, presente e futuro, a rintracciare una comprensione, un senso possibile dell’essere come presenza: dell’io effettivo. Se l’essere è strutturalmente temporale, comunque, nella contraddizione ontologica, non è meramente riducibile alla mera presenza, datità e attualità. La possibilità dell’essere consiste nel come stare nel tempo. In questo scenario di “crisi”, l’esperienza della storia è radicale e ontologicamente costitutiva per interpretare la sua relazione con la filosofia. Non dimentichiamolo. La filosofia, storicamente, nella ricerca del vero, del giusto e del buono, ha la sua origine come risposta ad una paradossale ingiustizia: la condanna e la morte di Socrate. Sapere come agire bene, dire e fare la verità è ciò che ci spinge a filosofare. Nella dismisura dell’umano, nello spazio disseninato e ambiguo della relazione, la giustizia è tutto: nella forma e nella sostanza.
A proposito, qual è il rapporto tra la storia, il vissuto, gli accadimenti, e la filosofia?
Dobbiamo riconoscerlo. Nella contemporaneità Hegel ritorna sempre a inquietare la nostra condizione esistenziale. Tra storia della filosofia e filosofia pratico-politica è indubbio che oggi Hegel is back come interlocutore di rilievo nel dibattito filosofico. Hegel, infatti, ci ricorda come la nottola di Minerva spicca il proprio volo “sul far del crepuscolo”. Ciò significa che la filosofia, il bisogno di filosofia, in epoca di crisi, si manifesta quando “una” storia volge alla sua conclusione, alla sua “fine”. La filosofia comprende pervasivamente la storia (anche la propria). Noi possiamo comprendere “una” storia muovendo dalla sua “fine”. La “fine” di “una” storia denota la coincidenza dell’inizio della comprensione e ricostruzione del tutto, della realtà. Anche il nostro tempo hegelianamente è il compimento della sua storia, della sua “fine”, della fine di una sua “forma”. Lo spirito del tempo, nelle morfologie del conflitto, può farci intendere altre e nuove qualità dell’agire umano nelle quali, come ha detto Massimo Cacciari, “la fine (del fine) della storia” non può esser fatta coincidere con “la fine della storia”, perché è dall’interno delle sue possibili configurazioni che “può maturare l’energia capace di imporre di nuovo un fine al divenire”. Nella sua mediazione immediata, il destino dell’umano essenzialmente fragile, il suo agire, si svolge nel tempo, nella storia: non c’è storia senza essere umano. Ogni individuo è figlio del suo tempo e la filosofia è il proprio tempo colto in pensieri. Tra contingenza, situatezza e apertura, l’uomo è tempo. Nel suo “teatro” vive la propria energia vitale.
La storia del tempo attuale, tuttavia, non sembra volgere alla fine o, se vogliamo, si può solo teorizzare la sua fine. E allora, qual è la forma della nostra esistenza e delle nostre relazioni oggi?
Per risponderti non posso non delineare sinteticamente qui alcune fenomenologie della crisi e degli scenari della contemporaneità. Il secolo XXI è iniziato, e subito la scena umana della storia è stata caratterizzata da profondi sconvolgimenti economici, geo-politici e sociali, climatici e sanitari, mentre la natura, con il suo apocalittico e asfittico mostro “invisibile”, non ha mancato di far sentire il suo “squarcio vitale e lacerante”, pandemico, imponendo la distanza che provoca la paura del “tocco dell’ignoto” (come diceva Canetti). Paradigma immunitario, desocializzazione, relazione e libertà s’intrecciano in un ineffabile “labirinto” che segna l’inquieto vincolo dell’umano. Un tempo inesplorato ci attende dal punto di vista antropologico e filosofico per quanto concerne il complesso rapporto che intrama la vita, la natura, la storia, la tecnica e la politica, un tempo nel quale si ri-declina il senso e il significato della parola “progresso”. A fronte della imprevedibilità della direzione della “freccia del tempo”, anche per il filosofo, allora, non è facile rispondere alla domanda: che succede oggi, nella nostra contemporaneità? Altrettanto non lo è per approntare una diagnosi del presente che possa illuminare gli aspetti salienti ma anche più controversi della complessità del mondo in cui viviamo.
Ma, di questa inquietudine, qual è la lettura che ne da la filosofia politica?
Nel nostro tempo, dominato dall’immediatezza, tutto avviene velocemente e muta continuamente; tutto, come ha osservato Elena Pulcini, “si mescola, lasciandoci orfani di parametri certi e consolidati”. Di fatto, “lo scenario per alcuni versi rassicurante della modernità solida, con i suoi codici e le sue regole, le sue istituzioni stabili e la fiducia nel progresso e nel futuro, ha ceduto il posto a una situazione magmatica, in cui assistiamo alla scomparsa di valori universalmente condivisi e al dissolversi delle certezze, alla crisi delle istituzioni e ai processi di individualizzazione, al trionfo dell’effimero e del transitorio e alla perdita del futuro”. Di fronte a questi esiti che segnano pervasivamente non solo il disagio, ma anche un vero e proprio possibile “declino” della modernità, c’è chi ritiene che gli effetti di insicurezza e di rischio prodotti dalla glocalizzazione, dalle pandemie, congiuntamente alle recenti sindromi populistico-plebiscitarie e alle metamorfosi dispotiche del “politico” e del capitalismo contemporaneo, siano ormai talmente preponderanti sulla complessità crescente della società, da creare, tra l’altro, vere e proprie patologie democratiche dall’esito virtualmente imprevedibile. Come hanno mostrato Ilvo Diamanti e Marc Lazar, nella dinamica politica contemporanea e nel quadro apocalittico del presente, la “popolocrazia” si appalesa, soprattutto nelle crisi storiche, economiche, sociali e culturali e, quindi, politiche, come la “nuova” e contraddittoria forma della democrazia rappresentativa, ingenerando la delegittimazione dei governanti, delle istituzioni, delle regole e delle norme vigenti, delle procedure di mediazione.
Un mondo sofferente, quindi, ammalato di patologie “democratiche”. Può azzardare una diagnosi più approfondita?
Possiamo provarci. Nel suo libro How to Run the World, Parag Khanna ha scritto che “il mondo attuale conosce modelli politici ed economici concorrenti, e l’attrazione esercitata dall’uno e dall’altro non dipende dalla sua democraticità, bensì dalla capacità di garantire benefici materiali alle persone”. Secondo Khanna, “quando l’economia di un paese democratico è in difficoltà la democrazia è la prima a soffrirne, mentre quando l’economia di un paese autoritario fiorisce, il regime in carica è il primo a trarne vantaggio”. Dunque, conclude Khanna, “la democrazia ha bisogno del capitalismo per affermarsi, mentre il capitalismo non ha bisogno della democrazia”. A sua volta, nella democrazia post-politica e nella “società del rischio”, secondo Slavoj Žižek, il sistema capitalistico globale contemporaneo si sta avvicinando “a un apocalittico punto zero”. I suoi “quattro cavalieri dell’apocalisse”, come sostiene il filosofo di Lubiana, comprendono “la crisi ecologica, le conseguenze della rivoluzione biogenetica, gli squilibri interni al sistema stesso (problemi con la proprietà intellettuale; imminenti lotte per materie prime, cibo e acqua), e la crescita esplosiva delle divisioni ed esclusioni sociali”. Inoltre, entro il quadro complesso di quelle che Daniel Bell ha chiamato le “contraddizioni culturali del capitalismo”, secondo Žižek il capitalismo odierno funziona sempre più come “l’istituzionalizzazione dell’invidia”, cioè quella sorta di implacabile “verme roditore” (Cervantes), di passione implosiva, che, rodendo l’anima e corrodendo l’identità, “ci spinge a sacrificare noi stessi pur di non concedere niente all’altro; o, ancora peggio, a trascinare gli altri, tutti gli altri, nel gorgo della nostra sconfitta, preferendo un’uguaglianza negativa, un’uguaglianza nell’annientamento, all’intollerabile peso della differenza”.
Uno scenario sconcertante, dovuto a un intreccio di concause dovute alla modernità in buona sostanza al progresso, è così?
Gli analisti politici critici hanno proposto le loro diagnosi. In questi scenari della nostra contemporaneità definita come l’epoca delle passioni tristi, nel tentativo di approntare un’interpretazione critica capace di spiegare i motivi di questa crisi, come ritiene Stefano Petrucciani, “molti si sono interrogati sul futuro di una democrazia che vede materializzarsi, dietro il suo volto formale, una deriva oligarchica legata all’acuirsi della distanza tra governati e governanti e alla concentrazione, nelle mani di questi ultimi, dei codici di riproduzione simbolica e materiale della so-cietà”. Le dinamiche della crisi, derivanti dall’intreccio di una molteplicità di diverse cause (economiche, geo-politiche, climatiche, pandemiche, sanitarie, culturali), hanno prodotto non solo un incremento delle disuguaglianze sociali ma hanno altresì modificato “il ruolo” del conflitto che segna il vincolo umano nel Moderno. Occorre ribadire quanto ha detto con enfasi Ágnes Heller: “la modernità è fondata sulla libertà, ma la libertà è un fondamento che non fonda”.

Quasi un “soffocamento”. Come ci muoviamo nello spazio immediato e ridotto del contemporaneo?
Vi ringrazio per questa domanda perché mi consente, nella possibile risposta, di concentrarmi sul termine “spazio” che avete richiamato. Nel nostro tempo, il divenire spaziale e urbano dell’essere ci pone nell’urgenza. Attraverso la lezione di Georg Simmel, abbiamo appreso che lo spazio non è mai unicamente un aspetto oggettivo, un a priori meramente kantiano che, insieme al tempo, è indifferente ed equivalente in tutte le sue forme, ma dev’essere considerato anche in relazione a determinate funzioni specificamente psichiche e a peculiari sue configurazioni storiche, esso è “un’attività dell’anima”, ovvero è nel contempo “condizione e simbolo dei rapporti tra gli uomini”. Oggi una nuova stagione di ricerche e di riflessioni, in cui si parla sempre di più, in ambito filosofico e geofilosofico, di spatial turn, di spatial thinking e di spatialization of the temporal, si sta aprendo, rideclinando con nuovi paradigmi il tema dello spazio, del luogo, del territorio, della città, del paesaggio, della metropoli. Detto altrimenti, dell’abitare umano. Lo spazio che viviamo nel nostro tempo ci impone di rimettere in discussione il problema e l’esperienza umana della prossimità, della distanza e della mobilità quali manifestazioni (estetiche, psicologiche, sociologiche, storiche e politiche, economiche, sanitarie) diverse della spazialità entro le quali l’umano si appalesa. L’uomo quale mobile essere sociale che intrattiene, a partire dal suo corpo proprio, percezioni, appropriazioni, dislocazioni e relazioni personali e interpersonali di prossimità e di distanza tutte “intramate” dal processo dell’azione reciproca, che conferisce loro senso e significato non solo al loro principio d’identità ma anche in relazione alla vita delle cose, alla loro coscienza psichico-simbolica come pure al loro rapporto con il mondo esterno e che coinvolgono pienamente i sensi dell’organismo umano vivente.
Oltre le relazioni interpersonali, come si rivela l’uomo negli spazi urbani?
Attraverso e dopo Simmel, abbiamo potuto sempre più e meglio comprendere perché la città è un complesso esperimento del dare forma al divenire dell’essere, del donare forma alla contraddizione, al conflitto. La città del conflitto, la città dei conflitti. La storia della città è la storia delle differenti forme d’organizzazione dello spazio e della spazializzazione del tempo vissuto in questa forma. La città è sempre la patria della varietas (Cacciari). Anche se la città non esiste in senso stretto, perché esistono le città, che con il loro valore anche simbolico per l’umano, dimostrano che non si dà in assoluto un carattere programmabile della forma città e del territorio. Questo comporta l’insorgere di crisi della forma spaziale, perché noi non abitiamo soltanto più città, ma territori che ci impediscono di fissare limiti, confini, alla forma urbana, alla città, al divenire urbano dell’essere che vive sempre più una complessa contingenza post-metropolitana sia geo-politica sia geografica e sociale e, oggi, sanitaria. Dell’umano abitare significa stabilire, nella dialettica del conflitto vita/forme, pratiche di relazioni, connessioni, interdipendenze, attraversamenti di paesaggi ibridi e ibridati, tutti come abitanti di passaggio nel paesaggio umano dello spazio, naufraghi nell’infinito deterritorializzante.
Afferma che “non abitiamo soltanto città, ma territori senza limiti”. Quindi, è come se vivessimo in una landa desolata?
Forse è più appropriato parlare di un paesaggio senza luoghi, fuori luogo, di spazi diversificati, dis-continui, indifferenziati, moltiplicati, virtuali. “Non-luoghi” come li definisce Marc Augé. Ora viene da chiedersi: se, in questa disseminazione e dispersione dello e nello spazio, non siamo più luoghi, se non abitiamo più luoghi, come può la città pre-disporre luoghi? Quale forma urbis ci riserva il futuro nella contingenza del vivente?
Già, e allora con quali prospettive ci proiettiamo nel fututo? Come migliorare questa condizione sociale?
I problemi che l’umanità si pone sono i problemi che può risolvere. Il problema permane come l’orizzonte della soluzione, ma non esiste come tale in essa. Non c’è somiglianza tra problema e soluzione. Il cammino che va dal problema alla soluzione non è lineare, poiché la soluzione si appalesa comunque come una determinazione del problema, che è poi l’essenza di un mistero che inerisce alla verità come evento, che nel suo accadimento si configura sempre forgiata attraverso le sue contingenze, autocreandosi in esse. Non ci sono guardiani e intercessori unici del sapere, portavoci di un assoluto interamente dato, di un pensiero pensante in atto che possono inverare tale mistero nella sua ineffabile contemporaneità: una presenza del presente che, colta nell’orizzonte del suo accadere, non potrà non ricadere nel passato (l’accaduto) mentre si proietta nel futuro (il non accaduto).
Quindi, un divenire di cui siamo attori, unici responsabili della nostra esperienza?
Sì! Soltanto l’ineluttabile esigenza dell’abitare come accadere, come evento (sempre problematico), come atto in atto, antropologia politica dell’essere umanizzato, del farsi umano, nella sua in-dicibile immediatezza, nella sua singolarità, nella città del conflitto, nell’orizzonte della rappresentazione, traduce di volta in volta l’esperienza travagliata, materia ribelle del divenire, della vita nelle forme che caratterizzano con brusca e perturbante emergenza l’inquieto vincolo dell’umano nel suo continuo passaggio dal possibile al reale e viceversa.
Un passaggio, un vivere e un attraversare gli spazi che, tuttavia, devono sempre confrontarsi con il prossimo, con l’altro?
Certamente. Nell’epoca della mondializzazione del riconoscimento, che è anche l’epoca dello spazio come reticolo che si sviluppa nel tempo, “vivere insieme” da qualche parte significa comunque riconoscere l’altro nella sua differenza: il passaggio all’altro è ciò che segna la legge dell’essere e del luogo nella nostra esistenza quotidiana. Ciascuno si vede nell’altro, e ognuno vede attraverso l’altro. Questo “principio di reciprocità” che pervade la vita e le forme che configurano il centro gravitazionale antropologico-fenomenologico dell’individualità e della la società moderna, contemporanea, implica conflitto nelle relazioni di prossimità, fra individui e gruppi di esseri umani, modi di luogo, o meglio, punti dello spazio che tra esclusività, esistenza dei confini, fissazione, vicinanza e lontananza, distanza, mobilità – qualità fondamentali della spazialità e costanti antropologiche dell’umano essere al mondo –, comportano l’unire e il separare, costruire “strade” ma anche gettare “ponti” e chiudere “porte”. Come sostiene Simmel: “l’uomo è quell’essere senza confini che vive di confini”. Tutti questi dispositivi negoziano la nostra relazionalità.
Ancora il “conflitto”?
Il conflitto, secondo Simmel, è “la scuola dove l’io si forma”, e come tale delinea anche una spazialità delle dislocazioni del politico e dell’etico tra responsabilità, scelta e libertà. Questa è anche, tra l’altro, la questione del nostro tempo e che ci pone nella condizione di rispondere, tra l’altro, anche al problema: all’ombra di chi si avvilupperà il nostro destino umano? La salvezza verrà dalla scienza? Speriamo che questo problema, nell’ontologia politica del mondo, non ci deluda tragicamente e conservi ancora tutto il fascino della novità nelle forme di vita della contemporaneità, nell’immaginazione del domani, in una resilienza infinita, entro e oltre il palinsesto in frammenti dello spettacolo “live” sempre in onda. Destino umano. Mondo della vita, relazioni personali, socialità, cultura, lavoro, abitare umano, ambiente, nuovi modi di produzione, diritti umani, educazione, formazione, quadri cognitivi, comunicazione, consumo, potere, politica. Siamo in uno spartiacque epocale con la “quarta rivoluzione” in cui l’onlife dispiega, tra luci e ombre, altri potenziali di senso per l’essere. L’esercizio critico della ragione e del pensiero reclamano un’ermeneutica anche filosofica dell’“anima doppia della tecnologia” che la “nuova civiltà digitale” esprime.

Siamo al digitale o, come dice lei, alla “nuova civiltà digitale”. Recentemente ha parlato di “fisiognomica pubblica” e di “contraddizione prossemica” entro e oltre l’ethos moderno. In quali termini?
In estrema sintesi di pensiero. Oggi, l’“arte della prossemica” (Marrone) e l’essenza della socialità umana, nelle metamorfosi dell’ethos moderno e contemporaneo, sono state duramente messe alla prova. Il destino sociale dell’umano, sempre più aggrovigliato in corpi, nodi e reticoli comunicativi intersoggettivi mediati dalle tecnologie digitali e dall’intelligenza artificiale, è ancor più sottoposto a un nuovo regime topologico tra insecuritas e distanza. Gli umani intesi come “linee” (Ingold) attendono le codificazioni di una “nuova ecologia delle relazioni sociali” in cui si rideclinano le categorie spazio-temporali, culturali, etico-giuridiche, economiche, psicologiche, pubbliche e politiche di “vicino” e “lontano”, tra “personale” e “sociale”, che ridisegnano le nuove geometrie delle passioni e del conflitto nella “società automatica” (Stiegler). Mentre “siamo tutti recintati nel cerchio esterno della prossemica” (Barile), nuovi conflitti configurano le metamorfosi delle relazioni di reciprocità nella vita quotidiana, il cui “stile” è pervaso dalla nuova “rarefazione” del sociale che maschera, in un circolo vizioso, la prossimità e che si consuma nel passaggio dall’antropocene al negantropocene e che ci costringe a elaborare una nuova “ermeneutica sociale” capace di interpretare sia la “società isolata” sia l’eventuale “società liberata”. Inoltre, occorre osservare che una tra le tendenze inarrestabili della vita contemporanea è senz’altro quella di essere dominata, tra l’altro, dall’individualismo “postmoralista” segnato pervasivamente dal “crépuscule du devoir”, esclusivo delle società complesse entrate in una cultura del “post-dovere”, dell’al di là dell’imperativo, che si anemizza a contatto del “vivere meglio” e accentua tragicamente le diseguaglianze sociali, dove “se l’etica alimenta i media, la biologia e gli affari, il dovere assoluto di fatto regredisce”.
E in quanto all’etica del convivere?
Nonostante tutto, la contemporaneità mostra di essere comunque attraversata da una forte domanda di etica che esprime ancora il bisogno di fondare sulla ragione l’imperativo morale, di raggiungere l’universale valido, di diritto, per tutti, promuovendo la libera discussione, il discorso argomentato e razionale, il consenso, per tentare di ritrovare, nella comunicazione trasparente, una nuova ragione pratica e un nuovo concreto principio di responsabilità e giustizia che non trascurino affatto di tematizzare anche la concretezza del singolo, la sua individualità e la sua relazionalità con l’altro, e che sappia dare significato, nelle metamorfosi dell’agire etico e pubblico, al dovere, inteso come ciò che è individualmente “dovuto” e che solo nell’azione, nella storicità e nella vita può trovare nel Dasein dell’uomo una sua pur parziale verifica nella sua effettività e autonomia. Ora, già a partire dagli anni Ottanta del Novecento, nel pieno dell’epoca “après-devoir” (secondo la definizione di Gilles Lipovetsky), cioè nella società postdeontica, di fatto, “la condotta, liberata dalle ultime tracce degli opprimenti doveri illimitati, dai precetti e dagli obblighi assoluti, vagava nel pieno disarmo morale, incapace di gestire autonomamente alcun quadro di riferimento valoriale che neppure la società, nelle lotte autoriproduttive delle regole, riusciva a garantire”.
Una modernità che sembra aver perso il senso del dovere?
Sulle posizioni di Lipovetsky occorre sinteticamente soffermarsi per spiegare quanto egli intenda filosoficamente e sociologicamente quando parla di epoca della postmodernità come epoca del “crepuscolo del dovere” e postmoralista. Nel descrivere il passaggio dalla sacralità del dovere al crepuscolo del dovere tra premoderno, moderno e postmoderno, Lipovetsky, come ha indicato Furio Semerari, distingue sostanzialmente tre grandi epoche differenziate per ciò che concerne il modo occidentale di intendere il dovere: la fase premoderna, la fase moderna e quella postmoderna. Nella fase premoderna, i doveri dell’uomo erano concepiti e vissuti come doveri verso Dio e i doveri verso gli altri uomini come espressione e funzione dei doveri verso Dio. Rispetto alla fase premoderna, nella fase moderna “cambia l’oggetto, o il soggetto verso cui l’uomo ritiene di avere doveri: i doveri dell’uomo si secolarizzano e sono essenzialmente doveri non più verso entità ultraterrene, ma verso gli stessi abitanti della Terra o, meglio, verso quei particolari abitanti della Terra che sono rappresentati dagli altri uomini – o anche: da se stessi e dagli altri uomini. I doveri diventano doveri verso la comunità o il sistema di comunità di cui si è parte. In generale, nella loro interpretazione moderna e secolarizzata, i doveri mirano a realizzare il bene terreno dell’uomo (dell’uomo come comunità, come umanità)”. Se la modernità, emancipando i princìpi dell’azione morale dalla credenza religiosa e trasferendo i doveri dell’uomo dal cielo alla terra, mantiene “l’idea classica di dovere”, la postmodernità può essere definita “l’età della crisi o del crepuscolo del dovere” a causa della sua tendenza individualistica (narcisistica) che “tende sempre più a vivere per il presente e per quel che nel presente si può ottenere e che domani facilmente non sarà più disponibile” e che si esprime attraverso “una sostanziale indifferenza nei confronti degli altri”. Secondo Lipovetsky, questa indifferenza postmoderna, che non è vissuta tragicamente come un problema, dipende sia dal fatto che “l’altro non è più assunto come oggetto di un proprio dovere”, sia dal fatto che “l’uomo è sempre meno dipendente dal giudizio dell’altro, mostra di avere sempre meno bisogno di essere riconosciuto dall’altro, mira a essere se stesso, tende a realizzarsi a parte, a rendersi autonomo rispetto all’altro, sottraendosi essenzialmente alla logica della competizione, della rivalità e della gerarchizzazione sociale”. Nella costituzione di piccoli gruppi finalizzati all’individuazione di soluzioni di problemi di ciascuno si consuma, secondo Lipovetsky, un processo di “miniaturizzazione sociale” che esprime specularmente una forma di “narcisismo collettivo”.
Con queste tendenze individualiste, l’etica, ma anche la forma e la sostanza che fine faranno? In quest’epoca postmoderna, saranno surrogate con valori diversi?
Fermo restando che secondo Jürgen Habermas il Moderno è ancora un “progetto incompiuto”, diversamente, come sappiamo, Zigmunt Bauman rilevando la natura controversa e per giunta non l’unica possibile della “rivoluzione” postmoderna nell’etica, ha constatato criticamente la disinvoltura con cui “alla nozione dell’approccio postmoderno alla morale viene associata troppo spesso la celebrazione della ‘fine dell’etica’, della sostituzione dell’etica con l’estetica, dell’emancipazione estrema che ne deriva”. In questo modo l’etica stessa è denigrata o schernita “in quanto costrizione tipicamente moderna ora superata e destinata alla pattumiera della storia”. Nel contesto dell’interpretazione postmoderna della “rivoluzione etica”, secondo Bauman, Lipovetsky (con Le crépuscule du devoir) gioca senz’altro il ruolo di “cantore della liberazione postmoderna” e di inventore dell’“Era del vuoto” e dell’“Impero dell’effimero”, dal momento in cui sostiene che siamo finalmente entrati nell’epoca dell’aprés-devoir, ovvero nella società postdeontica, in cui l’idea del sacrificio di sé è stata ampiamente delegittimata: “gli uomini non provano l’impulso né il desiderio di perseguire ideali morali e salvaguardare i valori morali; i politici hanno chiuso definitivamente con le utopie; e gli idealisti di ieri sono divenuti pragmatici”. Pervasa dalla persuasione che è “vietato fare più del necessario”, la nostra epoca è caratterizzata dal puro individualismo (autocelebrativo e privo di scrupoli) e dalla ricerca della vita buona, condizionata dall’esigenza di tolleranza che può solo esprimersi nella forma dell’indifferenza. La conseguenza di tutto ciò è che “l’epoca dell’après-devoir può ammettere soltanto una morale residuale, minimalista”. Il fatto è che, come osserva Bauman, se si assumesse la descrizione di Lipovetsky come corretta ne deriverebbe la percezione di una condizione umana vissuta in una società “priva delle preoccupazioni morali, dove il puro è non è più guidato da un dovrebbe, e dove il rapporto sociale è separato dall’obbligo e dal dovere”. Per Bauman, invece, il compito del pensiero critico consiste proprio nel demistificare e andare oltre questa credenza e cercare di comprendere se “l’epoca postmoderna passerà alla storia come crepuscolo o come rinascita della morale”. La novità dell’approccio postmoderno dell’etica consisterà allora nel considerare i grandi temi dei diritti umani, della giustizia sociale, dell’equilibrio tra cooperazione pacifica e autoaffermazione personale, della sincronizzazione di condotta individuale e bene comune, come temi che ancora “non hanno perso della loro attualità”. Nella forma e nella sostanza, per usare il tuo linguaggio, Andrea, il problema è soltanto che essi devono essere visti e affrontati “in modo nuovo” e al servizio di un progetto emancipativo.
Come ha opportunamente sottolineato, l’umano è come permeato dal “vivere in tensione” tra l’essere e il dover essere. Inoltre il destino sociale dell’umano – è questa la posta in gioco – è antropologicamente e ontologicamente segnato dalla “contraddizione prossemica”. Dunque, l’io è costituito dal rapporto con l’altro, dallo “sguardo” dell’altro, dalla relazione di reciprocità e dalla lotta per il riconoscimento?
Tu adoperi correttamente un lessico simmeliano ed hegeliano nel pormi questa domanda. Pertanto ti rispondo a tono. Com’è noto dobbiamo anche alla Sociologia di Georg Simmel una delle più acute e affascinanti analisi della relazione di reciprocità (Wechselwirkung). Secondo la sua prospettiva relazionale, ogni singolo individuo, nel richiedere il riconoscimento del suo essere per sé, parimenti accoglie in sé ogni singolo individuo che a sua volta rivendica lo stesso diritto. In questa dinamica “ogni parte è negazione dell’altra, ma nessuna delle due può prescindere dalla sua controparte” (Calabrò). All’interno di questa dinamica fra opposte polarità costruiamo anche l’immagine dell’altro da noi come risultato di un processo analogico per mezzo del quale vediamo l’altro mediante ciò che sappiamo di noi stessi in un incessante gioco di rimandi tra l’Io e il Tu, due istanze legate tra loro da un rapporto di reciproca dipendenza/indipendenza. Nella costitutiva ambivalenza della relazione sociale, in cui si consuma il differente coinvolgimento che contraddistingue il rapporto con l’altro e la sua percezione, alle impressioni sensibili si accompagnano sempre sentimenti di piacere o di dispiacere, di benessere o disagio, di attrazione o repulsione che finiscono inevitabilmente con l’agire su di noi attraverso le risonanze soggettive (emozionali, affettive, estetiche).
Quindi un “ambiente” sociale dove, attraverso l’”osservazione reciproca”, creiamo automaticamente distinti “sitemi” sociali?
Precisiamo. Nell’interazione conoscitiva e pratica con l’altro, ancora con Simmel, occorre riporre particolare attenzione, dal punto di vista sociologico, alle funzioni peculiari che i differenti organi di senso svolgono nell’attivare differenti modalità attraverso cui avviene la connessione interumana, anche nella “prossemica urbana” e nella dialettica tra “distanza e vicinanza”: non solo la struttura dei nostri sensi e dei loro oggetti contribuisce a sorreggere tutti i rapporti umani, ma se essa fosse differente anche la nostra vita interindividuale si fonderebbe su basi anch’esse differenti. Tra le varie attività e funzioni dei singoli organi di senso una “prestazione sociologica assolutamente unica” è offerta dall’occhio, che, nella connessione e interazione dell’umano, “consiste nel guardarsi l’un l’altro”: in effetti, forse, “questa è la relazione reciproca più immediata e più pura che esista in generale”. Il ruolo fondamentale del reciproco guardarsi disvela che, nell’immagine che un uomo si fa di un altro, “ci è negato il sapere perfetto intorno all’individualità dell’altro”: nell’esperienza quotidiana noi attestiamo non solo una percezione frammentaria dell’altrui individualità ma confermiamo altresì l’impossibilità dell’umano di rivelarsi nella sua totalità. Per Simmel, “noi siamo tutti frammenti non soltanto dell’uomo in generale, ma anche di noi stessi. Noi siamo tutti abbozzi non soltanto del tipo uomo in generale, ma siamo abbozzi anche di quella individualità e unicità di noi stessi”.
È un po’ come, sotto il profilo della “forma”, guardarsi allo specchio e cercare aggiustamenti estetici per piacersi?
Nella configurazione e percezione dell’immagine sensibile di una persona, la prassi della vita ci spinge a formare l’immagine dell’uomo soltanto in base “ai frammenti reali che conosciamo empiricamente di lui”. Lo sguardo dell’altro integra questo “materiale frammentario” in quel che noi non siamo mai puramente e interamente, soltanto mediante lo sguardo, nei frammenti conoscibili, è data la possibilità all’essere umano di disporre di una dimensione di conoscibilità dell’altro che è preclusa a ogni approccio di tipo esclusivamente concettuale. Lo sguardo non solo rende visibile l’altro, ma contemporaneamente svela all’altro anche il proprio sé, l’io da cui parte lo sguardo, senza tuttavia riuscire a rivelarlo compiutamente: lo sguardo che io rivolgo all’altro per penetrare le sue intenzioni e i suoi sentimenti è, nel contempo, il modo e la relazione in cui più direttamente mi manifesto all’altro, esponendomi senza difese. La prossimità di questa relazione è sorretta dal fatto singolare che lo sguardo rivolto all’altro e che lo percepisce è esso stesso espressivo, e ciò proprio per il modo in cui si guarda all’altro. “Nello sguardo che assume in sé l’altro – dice Simmel – si manifesta se stesso; con il medesimo atto con cui il soggetto cerca di conoscere il suo oggetto, egli si offre qui all’oggetto. Non si può prendere con l’occhio senza dare contemporaneamente: l’occhio svela all’altro l’anima che cerca di svelarlo. Poiché ciò si attua evidentemente con l’immediato guardarsi negli occhi, qui si produce la reciprocità più perfetta in tutto l’ambito delle relazioni umane”. Oggi con lo “sguardo mascherato” la fisiognomica pubblica ha dilacerato ancor di più la “contraddizione prossemica”.

Una finestra da cui (come umani) guardiamo al mondo (umano) esterno a noi, con il desiderio di comprendere una reciprocità per dare e ottenere consenso?
Per decifrare la natura “ineffabile”, chiasmatica, della reciprocità, è necessario, per concludere, comprendere la dialettica tra identità, alterità e conflitti di riconoscimento, riferendoci ancora a Hegel, al filosofo che più di altri, come ha osservato Francesco Remotti, “ha avuto il coraggio teorico di mettere a contatto diretto identità e alterità, ovvero di fare penetrare l’alterità nel nucleo dell’identità a tal punto di farlo esplodere”. Con Hegel, nel percorso culturale della modernità, come è stato osservato da Rossella Bonito Oliva, si raggiunge un punto alto di determinazione della soggettività perché nel suo pensiero l’identità e l’autonomia del soggetto si distendono “dall’Io a un Noi e dall’individuale all’universale solo uscendo dalla staticità e dall’autismo per riconoscersi e ricostituirsi nella plastica e duttile capacità di inclusione di contenuti e tensioni che abbracciano la realtà spirituale, transoggettiva e intersoggettiva; insieme di cui e in cui si costituisce la vicenda umana. Non è un caso che rotta la compattezza sistematica, ciò che si fa problema è la soggettività stessa”. Attraverso Hegel abbiamo compreso che la posta in gioco è proprio il Kampf um Anerkennung, ecco perché la dialettica del riconoscimento disvela un “momento agonistico, conflittuale” che ci presenta un soggetto da non considerare mai come un dato, bensì sempre come “una conquista”.
Ma la “conquista” del riconoscimento in cosa consiste?
Nella lotta per il riconoscimento, l’autocoscienza non è mera proiezione dell’identità dell’altro, ma attestazione e affermazione di se stessa come differenza, come opposizione, e che non si risolve in un superamento dell’intersoggettività e che si può manifestare soltanto riconoscendo e presupponendo l’esistenza di una pluralità di autocoscienze antagonistiche, di quegli “altri reali” che chiedono riconoscimento reciproco. Come ha detto il mio amico Remo Bodei, hegelianamente, “il soggetto abdica alla propria presunta sovranità originaria, rischia la perdita di sé e guadagna la propria identità a contatto con l’alterità e l’oggettività. Non si diventa infatti soggetti per diritto divino, a partire dalla purezza dell’Io=Io”. Se, come sostiene Hegel, “ognuno pone sé nella coscienza dell’altro, toglie la singolarità dell’altro, ovvero ognuno pone nella sua coscienza l’altro. Questo è in generale il reciproco riconoscere (Anerkennen)”, allora possiamo dire con Remotti, che per Hegel, il riconoscimento è “un superamento dei confini, è un essere l’io negli altri e gli altri in me, un noi dentro agli altri e gli altri dentro al noi”. Sono consapevole Andrea che leggere Hegel “è un gesto difficile”, ma per l’oggi è ancora indispensabile.
Siamo alle domande finali. In relazione al rapporto tra soggetti, dominio e potere, lei ha sviluppato una sua concezione filosofico-politica del conflitto. Che rapporto c’è tra conflitto e potere?
Vi ringrazio per questa domanda. Qui tocchiamo il nucleo “caldo” della nostra conversazione. Al riguardo, posso dirti che, nella mia prospettiva interpretativa, anche il conflitto non può che essere pensato processualmente nelle sue variazioni antropologiche, storiche e politiche compossibili che segnano – nel teatro della vita – l’ontologia politica dell’umano. Il riferimento al compossibile è ineludibile nella sua stessa differenza, cifra della relazione agonica, eccedenza che pervade ogni reciprocità, scandalo esistenziale che corrompe la ragione concettuale e la getta nel vortice vertiginoso del limite. Ragione e giudizio sono sufficienti per comprendere nella logica e nella vita del vivente che ruolo giocano il conflitto e il potere? Il conflitto c’è ed è antropologicamente pervasivo della condizione umana, agonica, antagonistica e contingente. Esso abita la vita del vivente e la sua dimensione intersoggettiva che caratterizza sia la fisiologia che la patologia sociale, i fenomeni e i processi biopolitici, economici, culturali e normativi. Sul piano filosofico, giuridico e politico, il conflitto non solo s’insinua ma si disloca nelle complesse trame, spesso antinomiche e contraddittorie, che strutturano e danno forma al rapporto tra corpo, persone e cose, riconfigurando la stessa scala dei valori.
Ma, a suo avviso, potrebbe essere possibile vivere senza conflitto?
Storicamente nessuna società è riuscita ancora a neutralizzare e a concludere il conflitto, perché esso è immanente alla struttura sociale. Se gli uomini vivono in società nell’eterogeneità di forme differenziate, se l’essere è sempre sociale ed è la politica che lo trasmuta in forma, allora il conflitto, come ci ha mostrato anche Claude Lefort a partire dalla filosofia politica di Machiavelli, è la trama ontologica dell’istituzione del sociale. La vita, nel flusso del suo divenire, non può che oggettivarsi in forme che la contraddicono in una struttura dialettica che affonda le proprie radici nella realtà, anche nei momenti tragici della storia in cui si esprime acutamente la massima lacerazione dell’essere. Nella differenza ontologica, che forgia la concretezza stessa del pensare filosofico e della sua interrogazione radicale, emerge il carattere intersoggettivo del conflitto: quel “démone” che irradia, in ogni essente, le relazioni umane che lo determinano. Esso agisce e il nostro corrispondervi è traccia e segnale della simultaneità del suo apparire, della manifestazione della sua concreta presenza intramondana.
Quindi, è impossibile neutralizzarlo anche perché si manifesta in forme differenziate?
Il conflitto c’è e si dice in molti modi, ma contemporaneamente disvela e indica la polivocità dei modi in cui si dice e si appalesa nella determinazione di ogni sua specificazione. Per l’interrogazione filosofica è dunque fondamentale rispondere alla domanda: come è possibile il conflitto? Come comprendere la natura della cosa e della sua infinita ripresentazione nella scena dell’umano e nella connessione del suo molteplice e delle sue forme nel segno della sua, nel tempo, irriducibile, differente, ipseità? Ciò premesso, come va intesa la presenza plurale del conflitto? Essa può forse essere ipostatizzata come se fosse un “oggetto” universale? Essa è segnata da una assoluta disvelatezza? In che modo, nelle condizioni del suo divenire, disegnandola, essa si manifesta nella sua materia, nella sua forma? La presenza del conflitto implica la predicazione con l’altro da sé. Questo riferirsi è condizione costitutiva di ogni predicazione e di ogni giudizio su di esso? Qual è la “verità” del suo apparire? Nel dispositivo del discorso, il lógos, come coscienza che riconosce il proprio limite (che richiede apertura e non può mostrarsi come conclusivo e non è l’ultima parola, l’ultima luce che lo illumina) è in grado di soddisfare a queste domande reciprocamente connesse? Il realissimum del conflitto c’è nelle intramondane e corruttibili cose e vite dell’umano.
Tutto sommato, un umano positivo, che ragiona per comprendersi.
Con Max Weber possiamo dire che “noi abbiamo bisogno d’interpretare il senso dell’agire”. Come ente corruttibile, composto di materia e forma, l’umano esige di risalire alla sua causa, per comprendersi in un circolo del potere che comprende entrambi l’altro e la propria ipseità. Nel limite del definibile, nella pensabilità del conflitto, il circolo del sapere non può che essere salvato, perché occorre un’epistéme che ne possa determinare gli elementi e le forme. Venendo a mancare la relazione con l’altro da sé si nientifica ogni possibilità di comprensione della propria, in-definibile, concretissima, singolarità agonica (materia di un tutto che forma un tutto). Come si può annientare la possibilità dell’alterità che abita la vita, di cui siamo “ospiti”, dal momento che questa esigendo il suo “contrario” può acquisire, a livello esperienziale, tra biografia e storia, tra opposizione e conflitto, senso e forma nello spazio della libertà? A lezione da Simmel abbiamo appreso che tutto è in relazione: il soggetto, in quanto individualità, nel limite della vita, esperisce l’alterità, nella sua drammaticità, come esperienza di riconoscimento nel gioco reciproco di responsabilità e libertà che segna l’inquieto vincolo dell’umano.
Nella forma e nella sostanza, il conflitto sottende una forma di socialità?
Per l’essere umano, il soggetto contingente, che vive la “dissonanza” del dualismo cooriginario tra individuale e sociale come correlatività, il conflitto, si è detto, “è la scuola in cui l’io si forma”. L’io, frammento della vita, nella dimensione individuale/sociale, creando alterità, è sempre “a caccia di se stesso”: ciò segna pervasivamente il “mistero della socialità”. La presenza del conflitto, che non esaurisce il presente del suo dire nella mera linearità imperfetta, proprio perché la presenza è più che presente, eccede, perciò non è mai dominabile anche nell’infinita destinazione del pensare, rimanda a una causa e la ragione filosofica viene chiamata a dare spiegazione e interpretazione delle sue componenti essenziali. Se l’Uno del potere è numerabile, il conflitto è plurale, la sua traccia porta oltre, marca la sua cifra nell’ontologia politica dei soggetti, ne timbra la singolarità irriducibile di ognuno nella finitezza del loro essere, del loro apparire, del loro evento come segno del loro esistere che si rivela fenomenicamente. Come nel conflitto, anche nell’apparire siamo immersi. La fenomenologia dell’apparire si rivela nell’ontologia del limite, della finitezza. La filosofia politica del conflitto è anche una filosofia del limite. Nelle sue variazioni, il conflitto appare, si disvela.

La sua fenomenologia allora lo potrebbe contenere?
Non proprio. Il suo apparire non ne riduce il fenomeno al mero contingente. La morfologia errante del fenomeno non annulla il suo conseguente e cangiante apparire. Pensare l’annullarsi del conflitto è come pensare astrattamente l’annullarsi del finito, l’irriducibilità della sua presenza determinata. Nessuna esperienza può dire aprioristicamente quale sia il destino del conflitto: anche il senso comune pensa e dice del conflitto come qualcosa di “reale” che persiste. Tutti facciamo innegabilmente esperienza del conflitto. La certezza negativa del suo esserci c’è sub specie aeternitatis. Ma noi non possiamo dire che c’è, se non quando appare, quando esplode e implode, quando lo rendiamo compossibile nel suo actus essendi, sempre finito, differente, ma comunque comune, generale, attuale, immediato, nel suo compiersi, nella sua vita in atto, sensibile, segno del tempo e dello spazio, che scandalizza ed eccede la conoscenza razionale a priori, che illude il potere della ragione.
Ciò vuol dire, allora, che la fenomenogia del conflitto va continuamente studiata, giusto?
Sì! La filosofia politica del conflitto, nel limite della sua validità, tratta della materia del suo apparire, cercando di comprenderne il senso e di spiegarne e rappresentarne l’oggetto come esperienza empirica probabile, possibile, temporalmente determinata, variabile, descrivibile-rappresentabile, come res che non è costruita dalla ragione stessa, ma che ha a che fare con il potere, con i suoi luoghi, le sue forme, le sue pratiche, le sue simboliche, le sue tragedie: i suoi conflitti, perché prepotente e abitato dalla boria della corruzione, missione dolorosa e piacevole dell’inetto, della sua miseria ontologica in cui è gettato nell’indicibile singolarità vissuta nella inesorabile finitezza della passione triste dell’utile che crea disuguaglianza, discrepanza, morte. Il dire del potere dice non solo della nostra finitezza ma ci espone, componendoci, al limite. La lingua del potere è la lingua inconclusiva, impotente, del limite che ci fa sanguinare e desiderare con i corpi, “abiti” biopolitici dell’essere. La lingua politica della vita che vive, pensa e muore nel conflitto. Una lingua inquietante, scabrosa, ruvida, che incontra il suo limite nel proprio esserci nell’immanenza del conflitto, che come forma locutionis, s’incarna come un marchio a fuoco nel linguaggio dell’essere, nella carne dell’io e che segna ogni differenza ontologica.
Una forma di potere che si perpetua con il linguaggio del conflitto per prevalere?
Pensiero e linguaggio del conflitto. La filosofia intende rendere evidente il senso della parola stessa: conflitto e potere. Proponendosi di dare a intendere ciò che essa si prefigge di comunicare nel polimorfismo della sua esperienza, delle esperienze. Parola del conflitto, le parole del conflitto. Parola del potere. Le parole del potere. Cosa si può dire di ciò che non si è potuto dire, cercando di dirlo o sperando nella lotta di poterlo dire. All’interno dei limiti del linguaggio, qual è la missione della ragione filosofica nel comprendere e decostruire questo dire e/o non poter dire all’interno delle forme dell’essere che, nella relazione comune, declina la grammatica del suo idioma nelle forme del suo apparire, pensare, agire e parlare: fare? Figure del conflitto e del potere. Come può la filosofia politica figurarle, dipingerle nella “drammatica” delle civiltà, nei geroglifici dei furori, senza ammutolire di fronte alle vite offese, alle macerie dei corpi?
E come può?
Dopo, attraverso e oltre Machiavelli, navigando, nella modernità e oltre, con mappe non più servibili, ci si è resi conto criticamente nel tempo dell’impossibilità di porre fine a ogni forma di conflitto e ci si è posti nella prospettiva di ripensare il conflitto non soltanto nella possibilità del suo superamento, ma soprattutto in quella di pensare cosa possa significare, tanto a livello individuale quanto sociale, la “permanenza del conflitto”. Se l’ingovernabilità costituisce una delle cifre ontologiche essenziali della realtà dell’umano, della socialità umana, allora occorre comprendere l’impensabilità di ogni possibile rimozione del conflitto in quanto tale, dal momento che, con Eraclito, “pólemos, il conflitto, di tutte le cose è padre, di tutte le cose è re, e gli uni rivela dei, gli altri umani, gli uni schiavi, gli altri liberi”. Nei paesaggi frastagliati del conflitto, da una parte, c’è chi persegue una palese negazione e rimozione (sradicamento) dell’alterità e del conflitto che formano l’opacità, nella pratica del senso comune, dell’esigenza contemporanea di una possibile trasparenza securitaria delle relazioni individuali e sociali, prive di “ombre e doppi fondi” sia nell’utilità intesa come razionalità di tipo strumentale sia nell’intenzionalità quale forma di razionalità di tipo comunicativo. Dall’altra parte, invece, in modo oppositivo nei confronti di chi persegue la rimozione del conflitto, c’è chi sostiene esplicitamente la “necessità” dell’accettazione del conflitto quale espressione intrinseca del riconoscimento del pluralismo delle posizioni, ovvero di una molteplicità irriducibile a unità. Queste due contrapposte posizioni rivelano la ragione consustanziale, ontologica, del fatto che il conflitto ci interroga, nella sua complessità diversificante, sia sul piano teorico che pratico. I nostri contemporanei si trovano, dunque, come sconcertati di fronte al quesito eracliteo se riconoscere o meno che “il conflitto è padre di tutte le cose”. Ancor di più lo sono, nell’aria rarefatta della teoria e nella concretezza ruvida della vita quotidiana, quando vivono conflittualmente le metamorfosi che attraversano le loro relazioni di fiducia reciproca in tulle le possibili declinazioni che essa esprime nella percezione e nelle difficoltà del presente, soprattutto quando si è presi dal moral panics in cui viviamo la crisi delle certezze della vita quotidiana nella generale inquietudine collettiva. In quel momento il conflitto dilaga nell’eterna e hobbesiana insecuritas politica e l’emergenza, l’eccezione prendono il posto prevalente e incontenibile della scena umana.
Allora la conflittualità è insita nell’uomo?
Le è ontologicamente immanente, come dimostra il campo dell’agire politico. Nella condizione conflittuale, emerge una profonda crisi di fiducia e la diffidenza guadagna il sopravvento su tutto e la contingenza del sé si carica di diffidenza, rischio, ambivalenza, menzogna, relativismo eccessivo, e tutto si scorpora e si accorpa, come direbbe Elias Canetti, in “cristalli di massa liquida”. Le metamorfosi della politica riflettono specularmente quelle del potere e del suo “segreto velenoso”. Sì, perché, come sostiene Geminello Preterossi, “il potere è malattia e medicina, male e cura allo stesso tempo”. Non solo, il potere è anche una “medicina pericolosa” perché “punta sulla problematica della condizione umana e assicura di farsi carico dei suoi limiti strutturali, concentrandone e monopolizzandone il carico di violenza e paura, al fine di neutralizzarla per quanto possibile, di contenerne almeno parzialmente l’irrazionalità, l’imprevedibilità”. Il potere “parla di ciascuno di noi: è allo stesso tempo distante e interiorizzato, straniante e intimo, tanto alienazione quanto proiezione/rappresentazione collettiva”. Questo tipo di potere, con il suo “abbraccio che incute timore e sollievo, che cura e minaccia”, “rende tutti i consociati dei sopravvissuti”.
Per concludere, desidereremmo sapere: possiamo proteggerci dal conflitto? Ne sarebbe necessario?
Per proteggere la vita occorre creare le condizioni necessarie per poterla risparmiare e viverla con dignitas. Il che significa che “alle origini delle funzioni positive del potere, del suo addomesticamento, vi è la dilazione della sua violenza, che crea lo spazio e il tempo della sopravvivenza, ma mantiene al potere medesimo di tornare a manifestarsi quale pura forza”. Il nostro tempo è più che mai pervaso dalla “mediocrazia” del potere, qualità modesta che si pone nelle varie forme di vita e di lavoro in una posizione intermedia tra superiore e inferiore e che sembra essersi impossessata dell’oggi in quanto incapace di coniugare i propri fini utilitaristici con i valori della conoscenza e della cultura. In questo nostro confusissimo tempo il destino umano ancora non si è compiuto. Il gioco del vivere continua tra la libertà e le occasioni, tra essere e politica.
Tutti le notizie >